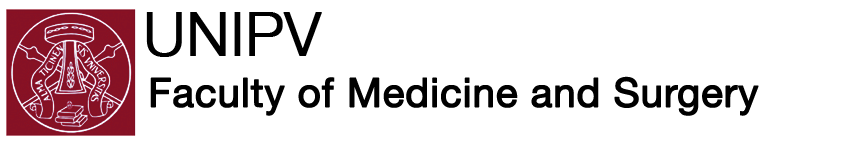FACOLTA’
Le origini della facoltà medica di Pavia coincidono con la fondazione dell’Università nel 1361, con atto del Sacro Romano Imperatore Carlo IV. Nel corso della sua storia secolare essa ha testimoniato in maniera significativa l’evoluzione delle scienze della vita in Lombardia.
Un’epoca di grande sviluppo degli studi medici pavesi è legato al Rinascimento, quando furono attivi Gerolamo Cardano, professore di medicina, Gabriele Cuneo, che descrisse il foro ovale interatriale, e Leonardo da Vinci che, pur non avendo avuto una affiliazione ufficiale universitaria, collaborò tuttavia nel 1510-1511 con il docente dell’Università Marcantonio della Torre. Insieme esplorarono la struttura del corpo umano; alcuni disegni conservati nella raccolta di Windsor sembrano attestare la produttività di questo sodalizio.
Il nome principale delle scienze medico-biologiche pavesi, nel corso del Seicento, fu certamente quello di Gaspare Aselli, scopritore del terzo tipo di vasi – i linfatici – e professore di anatomia nell’Ateneo pavese. Un punto di svolta fondamentale nella storia dell’Università di Pavia si ebbe a seguito delle riforme teresiane nella seconda metà del Settecento con la chiamata di illustri docenti, tra i quali Antonio Scarpa, massimo anatomista italiano dell’epoca, Samuel Auguste Tissot e Johann Peter Frank, entrambi professori di medicina, Giovanni Antonio Scopoli, professore di chimica e botanica.
Nel corso dell’Ottocento la Facoltà medica pavese mantenne un elevato livello scientifico e didattico con ricerche che influenzarono profondamente la storia delle scienze della vita. Fra i moltissimi studiosi che aumentarono internazionalmente il prestigio dell’Università possiamo ricordare Bartolomeo Panizza, scopritore dell’area corticale occipitale visiva, Andrea Verga, che identificò il cosiddetto ventricolo di Verga, Cesare Lombroso, che avvio gli studi di antropologia criminale ai quasi sarà poi associata la sua opera, Enrico Sertoli che ha lasciato il suo nome ad un tipo di cellule del testicolo, Edoardo Porro autore di una procedura cesarea programmata per salvare non solo il nascituro ma anche la madre, Carlo Forlanini inventore di una tecnica – il pneumotorace artificiale – che rappresentò il primo trattamento efficace per la tubercolosi polmonare. Nella seconda metà dell’Ottocento fiorì anche l’opera rivoluzionaria di Camillo Golgi che aprì un capitolo interamente nuovo nella storia della neurobiologia introducendo un metodo istologico attraverso il quale fu possibile definire l’architettura del sistema nervoso centrale. Golgi fu anche uno dei pionieri della citologia, grazie alla scoperta dell’apparato di Golgi, e della microbiologia per i suoi studi malariologici.
Nel corso del Novecento alcuni esponenti della sua scuola scientifica saranno protagonisti di importanti scoperte; tra questi Adelchi Negri che identificò i corpuscoli di Negri della rabbia, Emilio Veratti che definirà con precisione i caratteri morfologici del reticolo sarcoplasmatico, Aldo Perroncito che descriverà la morfogenesi rigenerativa del nervo periferico dopo trauma sperimentale.
Un’altra importante acquisizione scientifica che caratterizzò la rilevanza della Facoltà medica pavese nel corso del Novecento è legata agli studi ematologici di Adolfo Ferrata (e della sua scuola internistica) e all’idea rivoluzionaria da lui sviluppata di un progenitore staminale degli elementi figurati del sangue. Nel 1937 Pavia vedrà poi la scoperta della serotonina da parte di Vittorio Erspamer e Maffo Vialli, identificata inizialmente nell’intestino (e per questo motivo denominata allora enteramina) e in seguito caratterizzata chimicamente dallo stesso Erspamer.
Laureato nella Facoltà medica fu anche Luigi Luca Cavalli Sforza che poi collaborò con Adriano Buzzati Traverso della Facoltà biologica, la cui opera ha portato a importanti risultati nel campo microbiologico (scoperta dei batteri Hfr) e, soprattutto, a un grande sviluppo della genetica di popolazione attraverso la quale si sta ricostruendo l’albero genealogico dell’umanità.
Senza entrare in molti dettagli, importanti contributi novecenteschi sono anche quelli legati agli sviluppi della citogenetica, della clinica medica, della neurologia clinica, di molti settori della medicina specialistica internistica ed operatoria, della fisiologia e della biologia molecolare che stanno chiarendo rilevanti meccanismi nella patogenesi di molte malattie.